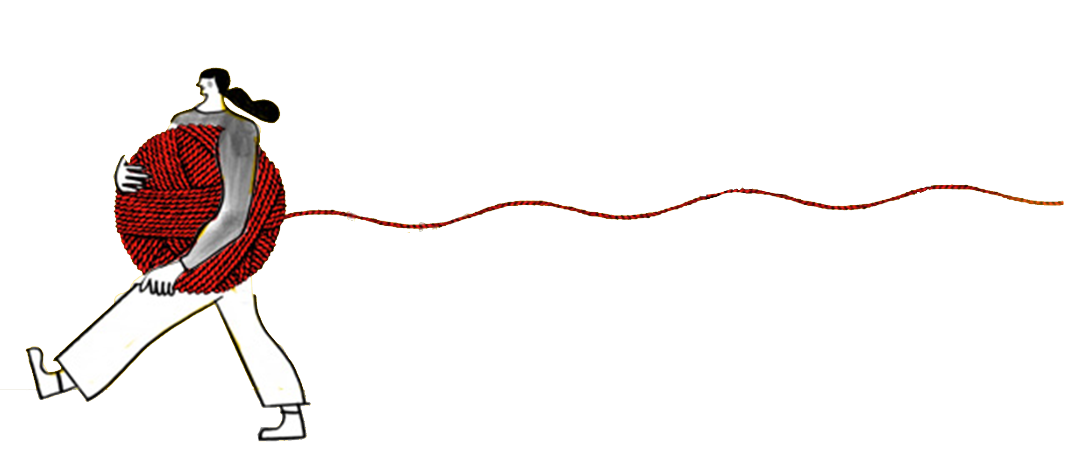A cosa servono le storie. Intervista a Daniela Mangini
La narrazione può essere un efficace strumento di orientamento, un modo per progettare il futuro senza mai perdere di vista il presente. Ce ne parla Daniela Mangini, giornalista e curatrice editoriale.

Le storie sono molto di più che semplici racconti: sono mappe, bussole, strumenti che usiamo – spesso senza rendercene conto – per orientarci nel mondo. Ci aiutano a dare significato agli eventi, a leggere tra le righe della realtà in tutta la sua complessità e a prendere decisioni, anche nelle situazioni più imprevedibili.
Daniela Mangini, giornalista e curatrice editoriale, ce lo racconta in questa intervista e ci parla del suo corso con Scuola Holden L’uso pratico delle storie. Competenze narrative per affrontare l’imprevedibilità del contesto: un percorso che parte il 26 febbraio per esplorare gli schemi narrativi, approfondire le quattro Intelligenze Relazionali e allenarsi a improvvisare decisioni migliori.
Raccontaci un po' di te, oltre il personaggio.
Quando ero bambina, aspettavo con ansia la pubblicità, perché mi affascinava essere catturata da tutte quelle parole, immagini e suoni combinati tra loro in maniera così emozionante. Cosa accendeva tutte quelle scintille in me? Fortunatamente non potevo ancora uscire con il portafogli, ma è da lì che è nata la mia curiosità per la magia della narrazione, per quel potere capace di rapire i sensi e l’immaginazione. Così ho deciso di studiare il dietro le quinte della suggestione.
Ancora oggi, mi affascinano gli oggetti, sia virtuali che materiali, e la carica di creatività che li accompagna. Anche le parole sono oggetti: hanno un colore, una profondità, una forma. Ho un pensiero molto astratto e mi innervosisco quando qualcuno mi definisce "razionale". Ma è vero che scavo sempre sotto la meravigliosa superficie delle cose.
Potrei descrivermi come un’antropologa da bar camuffata da giornalista: mi affascinano le storie che si intrecciano davanti a un bancone, che ha qualcosa di spirituale anche al di fuori del bicchiere, e mi ispira tutto ciò che emerge in un dialogo da tavolino, quando si perde la cognizione del tempo e ci si ritrova insieme in un’idea.
Negli ultimi anni, mi sto interessando a esperienze somatiche, alla loro importanza nel salvaguardare la nostra attenzione e sto esplorando l’arte del movimento, che credo andrebbe insegnata nelle scuole per contrastare la fuga dal corpo che il digitale ci impone. D’altra parte, le narrazioni non sono altro che il movimento della mente nello spazio che chiamiamo tempo.
Ci parli del tuo corso L'uso pratico delle storie?
Questo corso nasce da una riflessione: il giornalismo da solo non basta per permettere alle persone di orientarsi in autonomia. È necessario educare anche al presupposto del giornalismo, ossia la convivenza tra una pluralità di punti di vista e di voci e la consapevolezza della forza di parole e immagini nel condizionare le nostre decisioni economiche e non solo.
Credo che ogni storia sia uno strumento di metacognizione, utile per affrontare momenti di stress e decisione in contesti ambigui. Sapere che stiamo scegliendo una tra tante possibili narrazioni (e che abbiamo il diritto di farlo) alleggerisce il carico di responsabilità e ci mantiene aperti alla possibilità del cambiamento.
Nel corso ho unito i miei studi più recenti su complexity, soft skills e self-leadership con il mio precedente percorso nel design dell’esperienza. L’obiettivo è riscoprire la nostra capacità di auto-orientarci, anche in un ambiente complesso e ricco di direzioni.
Offrirò una “meta-prospettiva”. Dopotutto, siamo quotidianamente immersi in piattaforme che fanno capo al brand Meta: padroneggiare le competenze narrative significa migliorare la nostra metacognizione, osservando le cose con il giusto distacco per mantenere padronanza e autonomia di azione.
Penso che il corso possa essere utile a chi sente il bisogno di ripensare il proprio posizionamento e di raccontarsi in modo più autentico, a sé stesso e agli altri. Credo possa interessare anche a chi vuole affinare la propria capacità decisionale, attingendo a informazioni in un contesto mediatico e nelle relazioni di networking, imparando a bilanciare pensiero critico e insight. In ultimo a chi è curioso di capire come considerare le storie quotidiane – che siano libri, film o serie TV – come un mentore per lo sviluppo delle proprie Intelligenze Relazionali©.
Le narrazioni sono ispirazioni che spesso danno il movente alle nostre decisioni. Pensiamo al fenomeno del quiet quitting come forma di protesta e alla figura di Bartleby, lo scrivano di Melville come modello. O a come la reputazione di una professione possa cambiare a seconda di come viene raccontata, nei giornali, nei film, nei documentari, influenzando le scelte degli studenti e la ricerca di senso nel lavoro stesso.
Oggi si parla molto di Employer Branding proprio perché le aziende hanno capito che le persone non si accontentano più della vecchia narrazione dell’etica del lavoro. Vogliono raccontarsi in modo più stratificato, difendere la propria identità e partecipare attivamente alla narrazione del brand, senza esserne solo strumenti.
Un gioco di interpretazione: alcune domande per andare oltre la prima lettura della realtà.
A quale parte di me sta parlando una storia? (Alla mia immaginazione, ai miei sensi, al mio pensiero o alle mie emozioni? E se provo a spostare la mia prospettiva, mi sento comunque rispettato o qualcosa non torna?)
Quante altre prospettive potrebbero emergere se ampliassi il tempo e lo spazio della mia osservazione? (Sto guardando solo un frammento o posso vedere una narrazione più grande?)
Qualcuno sta giocando con la mia attenzione? È un gioco utile?
Questo sguardo sulla realtà mi emoziona? E se sì, mi emoziona in modo troppo facile?