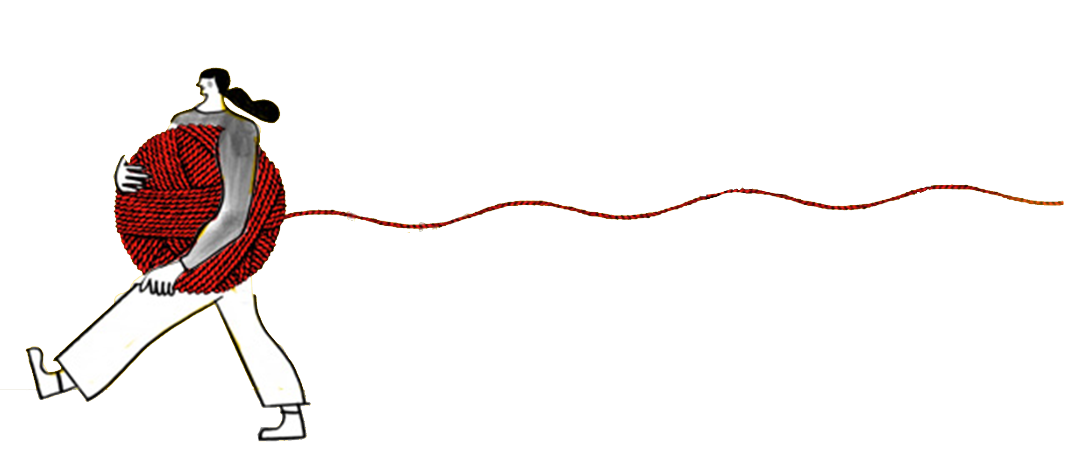L'articolo è stato realizzato da Giovanni Sedile all'interno del corso Scrivere di scienza: realizzare un prodotto di divulgazione scientifica, sotto la supervisione di Simone Angioni e dei docenti della SISSA di Trieste. Torneremo in aula con una nuova edizione del corso il 12 marzo.
Negli ultimi mesi è stata fonte di dibattito la decisione della Commissione Europea di abbassare lo stato di conservazione del lupo da “estremamente protetto” a “protetto” (a), una marcia indietro aspramente criticata dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). Questa modifica avrà il via libera da marzo 2025 se i paesi coinvolti non si opporranno.
Sull’orlo dell’estinzione alla fine degli anni Settanta, il lupo è stato inserito nella Convenzione di Berna come specie protetta vietandone qualsiasi forma di cattura, detenzione, disturbo e uccisione. In cinquant’anni, il numero di esemplari della specie si è moltiplicato, rappresentando un successo per la conservazione e la biodiversità, ma sollevando nuove sfide e paure soprattutto nelle aree dove l’animale era assente da tempo. Nella situazione odierna il lupo diviene facilmente preda delle fake news, che lo dipingono come pericoloso per l’uomo, alimentando la paura nei confronti di questo animale a cui si aggiunge lo scarso supporto o impreparazione degli allevatori e comunità locali.
Nonostante il divieto generale di caccia ai lupi esistono eccezioni per motivi di sicurezza pubblica. Con la decisione di declassare questo animale a stato “protetto” i vari paesi devono assicurarne la sopravvivenza, tuttavia possono agire per prevenire danni importanti attraverso metodi letali, come l’introduzione di quote di caccia. In paesi come la Svezia questa deroga viene interpretata in modo ambiguo, permettendo la caccia preventiva o immediata in caso di minaccia percepita. Attualmente è in progetto il possibile dimezzamento della popolazione di lupi (b).
Questa decisione molto controversa e per nulla etica è stata oggetto di diversi studi che ne mettono in discussione l’efficacia e in alcuni casi aumentano le problematiche. Una possibile soluzione, supportata anche scientificamente, sarebbe l’implementazione di metodi di prevenzione e campagne di informazione, una strategia decisamente più efficace per promuovere una coesistenza sostenibile tra esseri umani e lupi.
L’Odissea del lupo e il suo significato ecologico
Storicamente, il lupo è legato a un pendolo che oscilla tra venerazione e persecuzione. In Giappone, gli agricoltori lo pregavano al pari di un dio chiedendogli di cibarsi dei cervi che distruggevano i loro campi [1].
Al contrario, in Europa medievale e moderna il lupo divenne simbolo di natura incontrollata e distruzione, alimentato anche dalle favole dove incarna sempre il ruolo dell'antagonista spietato. In Italia comparve la figura professionale del luparo, cacciatore pagato tramite taglie messe sui lupi, che portò la specie sull’orlo dell’estinzione.
I vecchi testi scientifici consolidavano questa percezione negativa, definendo questi animali come feroci, inutili e irrequieti. A partire dagli anni Quaranta cominciarono i primi studi condotti su questo animale con una visione oggettiva e, con l’inserimento successivo nella Convenzione di Berna, ci fu un cambio di paradigma.
La figura del luparo, oggi ritenuta scomparsa, si ripresenta in altre vesti come fenomeno di bracconaggio, rappresentando il 30% delle morti della specie [2]. Ecologicamente il lupo riveste un ruolo fondamentale: all'apice della catena alimentare garantisce che al di sotto questa sia in salute e, predando ungulati come cervi e cinghiali, limita i danni alle coltivazioni e stimola la rigenerazione degli habitat.
Credenze e fake news
In Italia, il numero attuale è di 3300 lupi censiti (ISPRA), ma se ne stima un numero maggiore che preoccupa molti. La diffusione di questi animali non è da ricondurre a reintroduzioni o a migrazioni. La loro diffusione è stata possibile, oltre ai programmi di protezione, anche grazie alla loro capacità di dispersione e indole schiva.
Il branco - formato dai genitori alfa e dalle varie annate di cucciolate - occupa in modo stanziale un determinato territorio, difendendolo da altri lupi. Raggiungendo la maturità sessuale saranno i figli più grandi a disperdersi percorrendo centinaia di chilometri in cerca di un nuovo territorio non occupato da altri esemplari. Eliminare un branco da un territorio non garantisce che un altro non lo occupi di nuovo, rendendo tale soluzione inefficace a lungo termine.
Lo scorso settembre diverse testate giornalistiche locali del pisano raccontavano di un runner aggredito e ferito da due lupi (c). La presenza dei lupi veniva imputata a importazioni di sconsiderati, concludendo con il bisogno di utilizzare cartellonistica per avvisare del pericolo. Inserire cartelli che avvisino della presenza di animali selvatici nei boschi sembra paradossale. Pochi giorni dopo la stessa notizia è stata smentita da alcuni dei giornali, affermando che si era trattato di due cani fuggiti da una proprietà privata; altre testate non hanno fatto lo stesso.
È fortemente sconsigliato correre nei boschi, peggio se con auricolari: adattando il nostro comportamento al luogo che stiamo attraversando è possibile evitare spiacevoli incidenti. Sono disponibili diverse brochure informative sulle buone norme e comportamenti da tenere in caso di incontri ravvicinati sul sito Life WolfAlps.
Gli effetti degli abbattimenti: scienza e controversie
Le pratiche di abbattimento dei lupi vengono presentate come una soluzione per mitigare i conflitti uomo-fauna, sollevando controversie sia dal punto di vista scientifico che sociale. In Slovacchia, uno studio ha dimostrato che l’abbattimento regolamentato dei lupi non ha prodotto i benefici attesi: nonostante la rimozione degli individui non si è osservato una riduzione significativa delle perdite di bestiame, sottolineando che fattori come la disponibilità di prede selvatiche giocano un ruolo maggiore nella riduzione degli attacchi [3].
Negli Stati Uniti l’abbattimento di singoli individui ha portato alla diminuzione di predazioni in loco ma ha aumentato notevolmente il rischio di predazioni nelle zone limitrofe. Uccidendo un individuo si destabilizzano i branchi con dispersione di un numero di lupi maggiore, portando a comportamenti più imprevedibili e alla ricerca di cibo facile, e aumentando così il rischio di predazioni nelle aree circostanti [4].
Sempre negli Stati Uniti è stato analizzato come la liberalizzazione del controllo del lupo possa trasmettere un messaggio ambiguo, suggerendo che la specie abbia un minor valore. Gli autori mostrano che consentire l'abbattimento non riduce il bracconaggio, ma lo incentiva [5].
Questi risultati sottolineano una contraddizione fondamentale: le politiche di abbattimento che dovrebbero ridurre i conflitti spesso ne amplificano le conseguenze. Oltre a destabilizzare gli ecosistemi queste misure rafforzano percezioni sociali negative, alimentando la narrativa che vede il lupo come un problema da risolvere.
Prevenzione e buone pratiche
Anche in Germania il lupo è ricomparso dopo oltre centocinquant’anni. Dall’analisi di diversi metodi di prevenzione dei danni causati dai lupi, metodi come cani da guardiania e recinzioni elettriche hanno portato a una riduzione significativa delle predazioni, a volte del 100%. La loro efficacia si mantiene se le recinzioni sono ben tenute e i cani ben addestrati e in numero corrispettivo al gregge da proteggere. Il loro utilizzo richiede però formazione e costi iniziali rilevanti, il che può limitarne l’applicazione. Collegare l’adozione degli standard di prevenzione ai risarcimenti ha incentivato l’applicazione di queste misure, con una notevole riduzione dei danni nel tempo [6].
Altre misure confermano l’efficacia di pratiche non letali, evidenziando l’efficacia di deterrenti temporanei come i Fladry, recinzioni elettrificate con strisce colorate sospese. Queste pratiche efficaci a breve termine ottengono lo stesso risultato degli abbattimenti selettivi, risultando più etiche [7].
Entrambi gli studi sottolineano l’importanza di combinare più misure di prevenzione - adattate al contesto - per ottenere risultati efficienti e sostenibili che integrino supporto e formazione per ridurre i conflitti.
Nel Parco Nazionale della Majella il lupo non è mai scomparso. Vengono concesse tecniche preventive e un programma di restituzione degli animali predati. Grazie alle pratiche utilizzate le predazioni da parte dei dieci branchi di lupi locali sono inferiori al 5% della loro dieta. Il Parco collabora anche a livello internazionale formando altri allevatori europei.
Altrettanto virtuoso è il progetto Life WolfAlps, impegnato nella lotta al bracconaggio, oltre che alla prevenzione per la protezione del bestiame. Ad esempio, vengono impiegate squadre cinofile antiveleno per combattere la pratica dei bocconi avvelenati - pratica che, oltre a essere illegale e non selettiva, mette in pericolo sia gli animali selvatici che quelli domestici. Inoltre, Life WolfAlps diffonde notizie scientifiche corrette, scaricabili gratuitamente da diversi opuscoli informativi.
L’organizzazione Io non ho paura del lupo coinvolge la comunità per ridurre i conflitti. Dal 2019 si impegna nella conservazione a lungo termine del lupo tramite monitoraggio, prevenzione e corretta informazione.
Questi progetti possono fungere da modelli replicabili di gestione sostenibile.
Coesistere nel compromesso
Per affrontare i principali conflitti tra uomo e lupo è necessaria un’informazione basata su dati scientifici, tecniche di prevenzione, sensibilizzazione e supporto. Il lupo rappresenta il nostro rapporto con la natura, entrambi da noi tanto ammirati quanto temuti, sfuggenti al nostro controllo.
Come per altre situazioni di conservazione naturale, non esistono soluzioni assolute o definitive. La strada più efficace consiste nel perseguire un equilibrio sostenibile tra la salvaguardia degli ecosistemi e il rispetto delle esigenze delle comunità locali.
Sono pochi gli studi che hanno indagato il rapporto uomo-lupo in Italia. Ne è stato condotto solamente uno nel 1976 in cui è stato rilevato quanto i pregiudizi nei confronti dei lupi fossero fortemente correlati all’ignoranza [1]. Chissà quali risultati potrebbe dare questo studio ai giorni nostri.
Bibliografia
1. https://www.researchgate.net/publication/324439503_Wolves_and_Humans.net/publication/3244395 03_Wolves_and_Humans
2. https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.2006.00260.x
3. https://doi.org/10.1111/conl.12994
4. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189729
5. https://doi.org/10.1098/rspb.2015.2939
6. https://doi.org/10.4404/hystrix-23.1-4555
7. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00868
Sitografia
a. https://www.coe.int/en/web/portal/-/bern-convention-standing-committee-approves-eu-proposal-to modify-wolf-protection
b. https://www.corriere.it/animali/25_gennaio_02/la-svezia-apre-la-caccia-al-lupo-per-dimezzare-la popolazione-la-protesta-delle-associazioni-illegale-5dfed083-1f0e-4d58-baa9-6b294bc21xlk.shtml c. https://www.pisatoday.it/cronaca/attacco-lupi-vicopisano-13-settembre-2024.html
Note
https://www.parcomajella.it/
https://www.lifewolfalps.eu/
https://www.iononhopauradellupo.it/