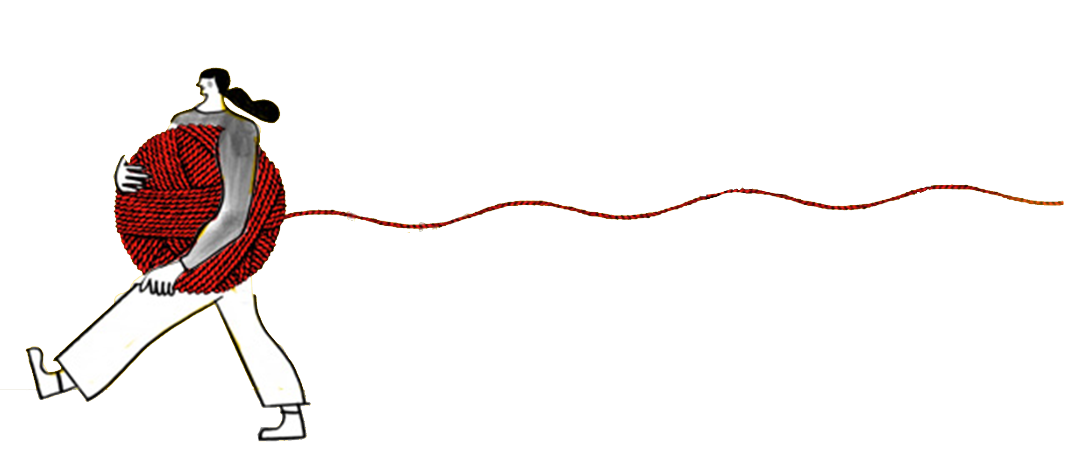Litio pulito: una soluzione che non asseta i territori
Una nuova tecnologia promette di ridurre l’impatto ambientale dell’estrazione di litio nel deserto di Atacama e contribuire a un futuro circolare per le risorse naturali.

L'articolo è stato realizzato da Giulia Buono all'interno del corso Scrivere di scienza: realizzare un prodotto di divulgazione scientifica, sotto la supervisione di Simone Angioni e dei docenti della SISSA di Trieste.
Nell’arido altopiano andino, dove Cile, Argentina e Bolivia si incontrano ad alta quota, si estende una delle regioni più importanti per la transizione energetica globale: il cosiddetto Triangolo del Litio. Qui, bacini sotterranei molto salati, chiamati salamoie, ospitano immense distese saline da cui viene estratto il litio, componente chiave delle batterie ricaricabili. Il problema è che per estrarre il litio in queste zone serve acqua. Tantissima acqua. E dove la domanda globale di batterie aumenta, le riserve idriche si assottigliano. Ma una nuova scoperta scientifica potrebbe cambiare tutto. Uno studio pubblicato su Nature nel marzo 2025 dall’Università di Birmingham presenta una membrana innovativa che, utilizzata con il processo di elettrodialisi selettiva, promette un’estrazione del litio più pulita e meno impattante sull’ambiente [1]. Si tratta di una tecnica in grado di separare in modo efficiente gli ioni di litio dagli altri sali presenti nella salamoia ottenendo come risultato finale un composto di litio quasi puro, pronto per essere trasformato in materiale per batterie, consumando molta meno acqua rispetto alle tecniche tradizionali. Un passo decisivo verso un’industria del litio che non asseta i territori.
Una membrana innovativa: come funziona
Ma come ci aiuta questa membrana quando si parla di estrazione del litio da acque salate? Immagina di dover separare un cucchiaino di zucchero da un’intera ciotola di sale. Complicato, vero? Ora prova a farlo quando tutto è disciolto in acqua e le particelle sono talmente piccole da non poter essere viste nemmeno al microscopio. Ecco, questo è lo stesso scenario, seppur in scala molto più grande, presente nelle salamoie, dove ioni di litio si mischiano insieme a una miriade di altri sali. Ma facciamo una breve deviazione: gli ioni sono atomi o molecole che hanno una carica elettrica, positiva o negativa, e si formano quando un atomo perde o guadagna elettroni. Ioni con una sola carica elettrica sono detti monovalenti mentre gli ioni con doppia carica divalenti. Gli ioni divalenti presenti nelle salamoie sono più grandi rispetto ai monovalenti, perché attirano un maggior numero di molecole d’acqua attorno a sé, formando un guscio più spesso. Ed è qui che entra in gioco la nostra membrana innovativa. Fisicamente, la membrana è un foglio sottile, flessibile ma soprattutto poroso poiché fatta di PIM, polimeri di microporosità intrinseca. Questi hanno una struttura interna rigida e ripiegata su sé stessa, che si organizza a formare una rete di nanopori – fori microscopici, pari ad appena un milliardesimo di metro! La forza di questa membrana sta proprio nei nanopori: grazie ad essi la membrana agisce come un filtro, lasciando passare solo gli ioni monovalenti più piccoli, come litio, sodio e potassio, mentre blocca o respinge quelli più grandi e divalenti, come il magnesio. In pratica, la membrana seleziona i potenziali candidati per l’estrazione finale.
E tra sodio, potassio e litio, sappiamo già chi vincerà questo “contest” chimico. Tuttavia, per trasformare questa selezione in un processo realmente efficace su larga scala, la singola membrana non basta: va integrata in un sistema completo, capace di dirigere gli ioni nella direzione voluta e di competere con i metodi tradizionali oggi in uso. Ed è proprio su questo punto che il confronto tra il vecchio e il nuovo si fa interessante.
Metodi a confronto: dove l’acqua è un tesoro
Per comprendere al meglio le differenze tra i metodi di estrazione tradizionali e quello proposto dal team dell’università di Birmingham, bisogna contestualizzare geologicamente l’altopiano andino, dove sono situate principalmente nelle salamoie oltre il 53% delle risorse mondiali di litio, il restante si distribuisce maggiormente sotto forma di rocce dure in Australia, Cina, Stati Uniti e in Europa. Nel cuore di questa regione si estende il deserto di Atacama, non a caso rinominato “il deserto più arido del mondo”. Infatti qui la pioggia è un evento raro e in alcune zone possono passare decenni senza una vera precipitazione. L’acqua che oggi si trova nel sottosuolo è il risultato di un processo lento e naturale, che richiede secoli per accumulare le riserve che oggi utilizziamo.
Le tecniche attualmente adottate per l’estrazione del litio prevedono di pompare la salamoia in superficie e lasciare che l’acqua evapori lentamente sotto il sole per mesi in vasche enormi e sorprendentemente colorate: viste dall’alto, si alternano in tonalità accese di verde, azzurro e turchese, in netto contrasto con il paesaggio arido del deserto.
Alla fine di questo lungo processo, rimane un residuo biancastro, ricco di litio, simile allo zucchero a velo. Questo tipo di estrazione consuma enormi quantità d’acqua dolce, 2 milioni di litri di acqua per estrarre una sola tonnellata di litio, l’equivalente di svuotare una piscina olimpica per ottenere una carriola di minerale. Di conseguenza, le attività di estrazione rischiano di consumare più acqua di quanto l’ecosistema possa naturalmente reintegrare [2], mettendo in crisi l’equilibrio ambientale e le comunità che da quell’acqua dipendono.
Il nuovo processo funziona in modo radicalmente diverso. Invece di affidarsi all’evaporazione solare, utilizza il principio dell’elettrodialisi: una volta pompata in superficie, la salamoia viene spinta attraverso una membrana grazie a una corrente elettrica, che genera un campo elettrico, una sorta di spinta invisibile che guida gli ioni verso la membrana, dove avviene la selezione mirata. Il risultato è una soluzione arricchita in litio dalla quale si rimuove parte dell’acqua per aumentare la concentrazione in litio tramite evaporazione controllata. Infine questa soluzione viene fatta reagire con una sostanza per ottenere carbonato di litio, una polvere solida che si separa naturalmente dal liquido e che può essere finalmente raccolta e utilizzata per le batterie.
Anche qui esiste una fase di evaporazione ma ha un ruolo completamente diverso: non è più il cuore del processo, ma solo una fase finale, controllata e veloce, senza vasche che vengono prosciugate totalmente consumando molta meno acqua dolce. Una possibile soluzione a molti problemi.
Questa innovazione offre la possibilità di estendere la stessa tecnologia anche a una gamma più ampia di processi per il recupero delle risorse, rendendo le membrane selettive un candidato promettente per ridurre gli sprechi su scala mondiale. Come afferma il dottor Qilei Song dell'Imperial College di Londra che guida il lavoro:
"La nostra ricerca potrebbe ridurre l'impatto ambientale dell'estrazione del litio e contribuire allo sviluppo di sistemi di accumulo di energia più efficienti per le fonti di energia rinnovabile. Potrebbero esserci anche applicazioni in altre aree del recupero delle risorse, ad esempio il recupero critico dei metalli dalle acque reflue, dalla plastica e, dal riciclaggio delle batterie".
In un contesto globale in cui serve ridurre l’estrazione di nuove materie prime, tecnologie come questa possono accelerare il passaggio da un’economia lineare, o usa e getta, a una circolare, in cui le risorse si riutilizzano, riducendo sprechi e impatti ambientali.
Anche se le membrane non sono una novità assoluta nel campo dell’estrazione selettiva, quella protagonista dello studio di Birmingham si distingue per due motivi fondamentali. Innanzitutto, la membrana realizzata con i PIM ha dimostrato maggiore selettività e velocità di trasporto degli ioni rispetto alle membrane già esistenti, e in questo contesto, velocizzare i tempi equivale a ridurre il consumo delle risorse idriche.
Inoltre, è l’unica membrana che ha dimostrato di poter funzionare non solo in laboratorio ma anche in un contesto industriale. Infatti, una delle sfide principali per l’applicazione su larga scala è quella di riuscire a mantenere prestazioni elevate anche quando sottoposta a flussi d’acqua industriali per vedere se selettività e stabilità nel tempo sono mantenute. Tuttavia, restano sfide aperte legate alla manutenzione, ai costi e all’adattamento in ambienti operativi complessi, soprattutto se parliamo di implementazione diffusa in zone remote. La strada verso un’applicazione industriale ampia è tracciata, ma non ancora completamente percorsa.
Per un futuro a basse emissioni e ad alta coscienza
Il concetto è chiaro: se vogliamo affrontare la crisi climatica, dobbiamo accelerare la produzione di veicoli elettrici. A questo si aggiunge una società sempre più digitalizzata, che richiede un numero crescente di smartphone, laptop e dispositivi portatili.
Tutto porta nella stessa direzione, ovvero un’impennata nella domanda di batterie ricaricabili, e quindi di litio. Ma la sua estrazione, se mal gestita, rischia di compromettere le stesse risorse che vogliamo proteggere. Se il litio serve una causa nobile a valle — alimentare la transizione energetica — altrettanto nobile dovrebbe essere il suo processo di produzione a monte. Il litio è il cuore di un futuro più verde e la sua origine dovrebbe essere pulita quanto il suo scopo. La catena che lo porta fino alle nostre batterie deve essere etica e rispettosa sin dall'inizio. Lo studio sulla membrana rappresenta una promessa: quella di poter continuare a innovare senza prosciugare. Bisogna quindi investire nella ricerca, capire come gestire le risorse idriche e, soprattutto, ascoltare chi vive nei luoghi da cui il litio proviene. Solo così potremo costruire un futuro a basse emissioni e che non lasci dietro di sé terre aride e comunità dimenticate.
Fonti
[1] D. Yang et al., «Solution-processable polymer membranes with hydrophilic
subnanometre pores for sustainable lithium extraction», Nat. Water, vol. 3, pp. 319–
333, Mar. 2025. doi: 10.1038/s44221-025-00398-8
[2] A. B. Kirshen et al., «Freshwater inflows to closed basins of the Andean plateau in
Chile, Argentina, and Bolivia», Commun. Earth Environ., vol. 6, Art. 177, mar. 2025,
doi: 10.1038/s43247-025-02130-6