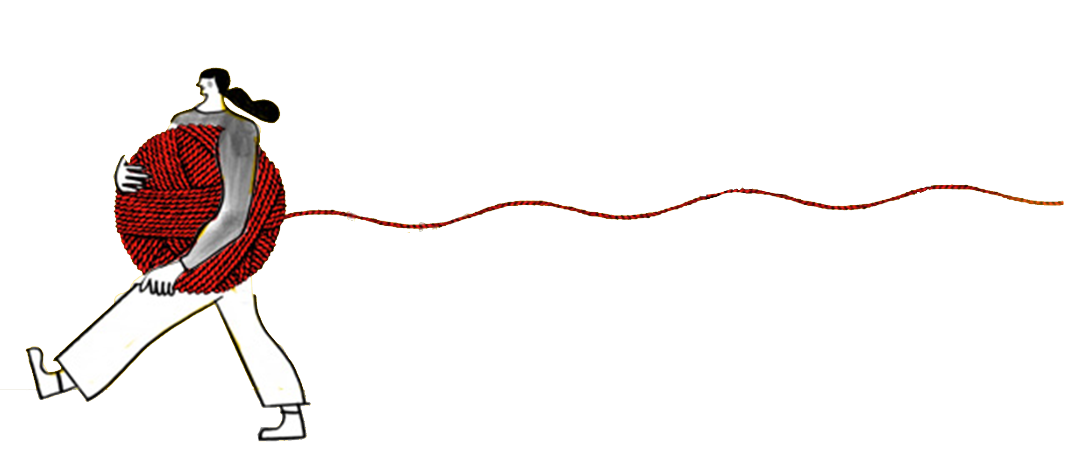Un videogioco al giorno toglie il medico di torno
Grazie ad una ricerca italiana i videogiochi d’azione vengono rivalutati come strumento terapeutico nella prevenzione della dislessia.

L'articolo è stato realizzato da Lucy Babicola all'interno del corso Scrivere di scienza: realizzare un prodotto di divulgazione scientifica, sotto la supervisione di Simone Angioni e dei docenti della SISSA di Trieste.
Nel 2024, secondo i dati ISTAT [1], nelle scuole italiane gli alunni con disabilità sono aumentati del 6% rispetto all’anno precedente. Tra questi, circa uno su cinque è affetto da un disturbo specifico dell’apprendimento, come la dislessia.
Una situazione che impone nuove strategie. E tra queste, la prevenzione potrebbe giocare un ruolo chiave. Soprattutto se a offrirla è un alleato tanto improbabile quanto efficace.
Sarà capitato a tutti di sentir dire almeno una volta il proverbio “Una mela al giorno toglie il medico di torno”. Ma se, al posto della mela, ci fosse un videogioco? L’idea suonerebbe sicuramente meno comune, e forse farebbe sgranare gli occhi a molti genitori e insegnanti, abituati a vedere nei videogiochi i principali nemici della pagella.
Eppure un recente studio coordinato da un team di ricercatori italiani e pubblicato su npj Science of Learning — una rivista del gruppo editoriale Nature [2] — ha portato alla luce risultati sorprendenti: i videogiochi d’azione, allenando l’attenzione multisensoriale nei bambini a rischio dislessia, sarebbero in grado di potenziare la consapevolezza fonemica, una capacità cruciale per l’apprendimento della lettura.
Gli ingredienti della lettura e come allenarli per prevenire la dislessia
Lo studio è stato condotto su 120 bambini in età prescolare, ai quali sono stati proposti compiti per valutare tre abilità fondamentali: consapevolezza fonemica, memoria di lavoro fonologica e denominazione rapida automatizzata.
Per capire meglio l’importanza di questi prerequisiti, provate a leggere una parola con un pizzico di attenzione in più, ad esempio proprio “dislessia”. Anche se per voi potrebbe sembrare semplice, durante la lettura il vostro cervello svolge una serie di operazioni complesse. Ad esempio, ha riconosciuto i suoni associati alle singole lettere (“d-i-s” forma “dis”), una capacità resa possibile dalla consapevolezza fonemica. Man mano che procedete lungo la parola, dovete ricordare i suoni letti in precedenza per integrarli con quelli successivi (“dis” con “l-e-s” per formare “dis-les”): qui entra in gioco la memoria di lavoro fonologica. Infine, se la parola è familiare, la riconoscerete al volo e, grazie alla denominazione rapida automatizzata, riuscirete ad accedere rapidamente alla pronuncia associata a quella sequenza di lettere/suoni, rendendo la lettura più fluente ed efficiente (“dislessia”).
Tutto questo avviene sotto il controllo di meccanismi attentivi, che aiutano a raccogliere le informazioni provenienti da diverse sfere sensoriali, a metterle insieme e a rimanere concentrati sul testo ignorando eventuali distrazioni. Queste abilità risultano spesso carenti nei bambini con dislessia. Per questo motivo, i ricercatori hanno coinvolto i partecipanti in prove specifiche per valutare proprio questi aspetti, dividendo poi i bambini in due gruppi: con e senza rischio di dislessia.
I bambini a rischio sono stati quindi coinvolti in venti sessioni di allenamento da 45 minuti l’una, distribuite in un mese e mezzo. Le attività proposte includevano: sedute di logopedia tradizionale, solitamente utilizzate con i bambini pre-lettori a rischio dislessia; mini-giochi mirati ad allenare il legame tra grafema (la lettera scritta) e fonema (il suono corrispondente); oppure videogiochi d’azione. Infine, un gruppo di controllo non ha svolto alcun allenamento.
I dati hanno mostrato che, tra queste opzioni, le sessioni con i videogiochi d’azione inducono un miglioramento delle performance, maggiore rispetto a tutte le altre.
In particolare, l’80% dei bambini a rischio che ha partecipato all’allenamento con i videogiochi d’azione ha mostrato un miglioramento nella consapevolezza fonemica superiore non solo rispetto ai bambini senza allenamento, ma anche rispetto ai gruppi coinvolti in sedute di logopedia, mini-giochi tematici, o la combinazione di queste.
Inoltre, questi miglioramenti si sono mantenuti stabili fino a sei mesi dopo la fine dell’allenamento, a conferma della stabilità degli effetti indotti dal trattamento, che perdurano nel tempo nonostante la sua interruzione.
Entrambi i risultati mettono in luce le potenzialità di questo tipo di allenamento nella fase prescolare, quando i bambini non hanno ancora iniziato a leggere. Un vantaggio che potrebbe aiutarli ad affrontare con maggiore sicurezza il momento in cui queste abilità diverranno fondamentali per imparare a leggere. Del resto, tanto nel videogioco quanto sui banchi di scuola, avere gli strumenti giusti (o l’equipaggiamento adeguato) può fare la differenza quando ci si prepara ad affrontare un attività particolarmente ostiche.
Come i videogiochi d’azione allenano il cervello
Il gioco è una componente fondamentale dello sviluppo, anche di quello del nostro cervello. Fin dai primi anni di vita, infatti, giocare consente ai bambini, così come ad altre specie animali, di esercitare e sviluppare abilità cognitive e di apprendimento. Questo è possibile grazie all’attivazione di specifiche aree cerebrali, particolarmente sensibili e plastiche durante la crescita. Il tutto, naturalmente, accompagnato dal piacere e dal divertimento che il gioco porta con sé.
Negli ultimi 30 anni i videogiochi sono diventati una delle forme di gioco più diffuse tra i bambini (e, diciamocelo, anche tra gli adulti). La loro crescente popolarità ha spinto i ricercatori ad approfondirne gli effetti sul nostro cervello, mettendo in luce un interessante potenziale terapeutico, in particolare nei videogiochi d’azione.
Pensando a titoli come il nostalgico Space Invaders o il più recente Mario Kart, questi videogiochi, apparentemente molto diversi tra di loro, condividono alcune caratteristiche fondamentali: la presenza di bersagli in rapido movimento e con traiettorie imprevedibili, che attivano la visione sia centrale che periferica, imponendo un elevato carico percettivo, cognitivo e motorio. Per affrontare queste sfide, il cervello deve reclutare in modo efficiente le aree coinvolte nel controllo attentivo multisensoriale, che, attraverso la pratica costante, si allenano e migliorano le prestazioni cognitive associate.
Per favorire questo controllo attentivo, entra in gioco un circuito cerebrale noto come fronto-parietale, che coinvolge le cortecce frontale e parietale. La comunicazione tra queste aree avviene tramite due vie: una ventrale, specializzata nell’elaborazione degli stimoli, e una dorsale, che ci permette di restare concentrati sugli obiettivi da raggiungere. La via ventrale, in questo senso, funge da interruttore [3] per quella dorsale, guidando l’attenzione verso gli stimoli potenzialmente rilevanti per l’azione da compiere. Perché questo passaggio di informazioni avvenga in modo fluido, è fondamentale il coinvolgimento di altre abilità cognitive, come la capacità di inibire gli stimoli irrilevanti, la memoria di lavoro e lo spostamento rapido dell’attenzione.
Ed è proprio qui che tornano in gioco i prerequisiti della lettura, con analogie sorprendenti. Guidare un kart su un percorso pieno di ostacoli durante un videogioco potrebbe non essere così diverso dal raccogliere e integrare informazioni multisensoriali nei processi di lettura. Gli autori dello studio ipotizzano che i videogiochi d’azione potenzino proprio i meccanismi di raccolta e selezione delle informazioni multisensoriali, permettendo un level-up non solo nel videogioco, ma anche delle abilità che saranno fondamentali nella lettura.
Un corretto funzionamento dell’accumulo di prove uditive, così come dello spostamento dell’attenzione, è infatti fondamentale per lo sviluppo adeguato della consapevolezza fonemica, prerequisito cruciale della lettura e indicatore affidabile del rischio di dislessia nei bambini pre-lettori.
I videogiochi d’azione, quindi, grazie alle abilità richieste per la loro esecuzione, potrebbero rappresentare uno strumento efficace per potenziare aree del cervello necessarie ad acquisire i prerequisiti della lettura, insegnandogli ad apprendere [4], con il valore aggiunto del divertimento.
Videogiochi e lettura: un’alleanza possibile
In un panorama scolastico sempre più complesso, forse è arrivato il momento di riscrivere le regole del gioco. Quel joystick, spesso considerato il nemico numero uno della pagella, potrebbe rivelarsi un alleato prezioso nella prevenzione dei disturbi dell’apprendimento, già a partire dall’età prescolare.
I ricercatori hanno tuttavia sottolineato la necessità di ulteriori approfondimenti, volte a identificare le finestre temporali ottimali anche per i prerequisiti che non hanno beneficiato dal trattamento proposto nello studio. In particolare, sarebbe importante comprendere la curva di sviluppo delle aree cerebrali coinvolte nelle restanti abilità necessarie alla lettura, per determinare quando e come sia più efficace stimolarle. Anche qui, proprio come in un videogioco, servirebbe individuare la giusta quest-line da seguire per ottenere il massimo risultato.
Nonostante ciò, questa ricerca apre la strada a un approccio innovativo: un uso dei videogiochi d’azione nella prevenzione della dislessia, calibrato sulle esigenze del bambino e sicuramente più gradito delle classiche mele.
Fonti
[1] https://www.istat.it/comunicato-stampa/linclusione-scolastica-degli-alunni-con-disabilita-anno-scolastico-2023-2024/
[2] Bertoni, S., Andreola, C., Mascheretti, S. et al. “Action video games normalise the phonemic awareness in pre-readers at risk for developmental dyslexia”. npj Sci. Learn. 9, 25 (2024). https://doi.org/10.1038/s41539-024-00230-0
[3] Corbetta, M., Shulman, G. “Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain”. Nat Rev Neurosci 3, 201–215 (2002). https://doi.org/10.1038/nrn755
[4] Green, C. S., & Bavelier, D. “Learning, attentional control, and action video games”. Current biology, 22(6), R197-R206 (2012). http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2012.02.012